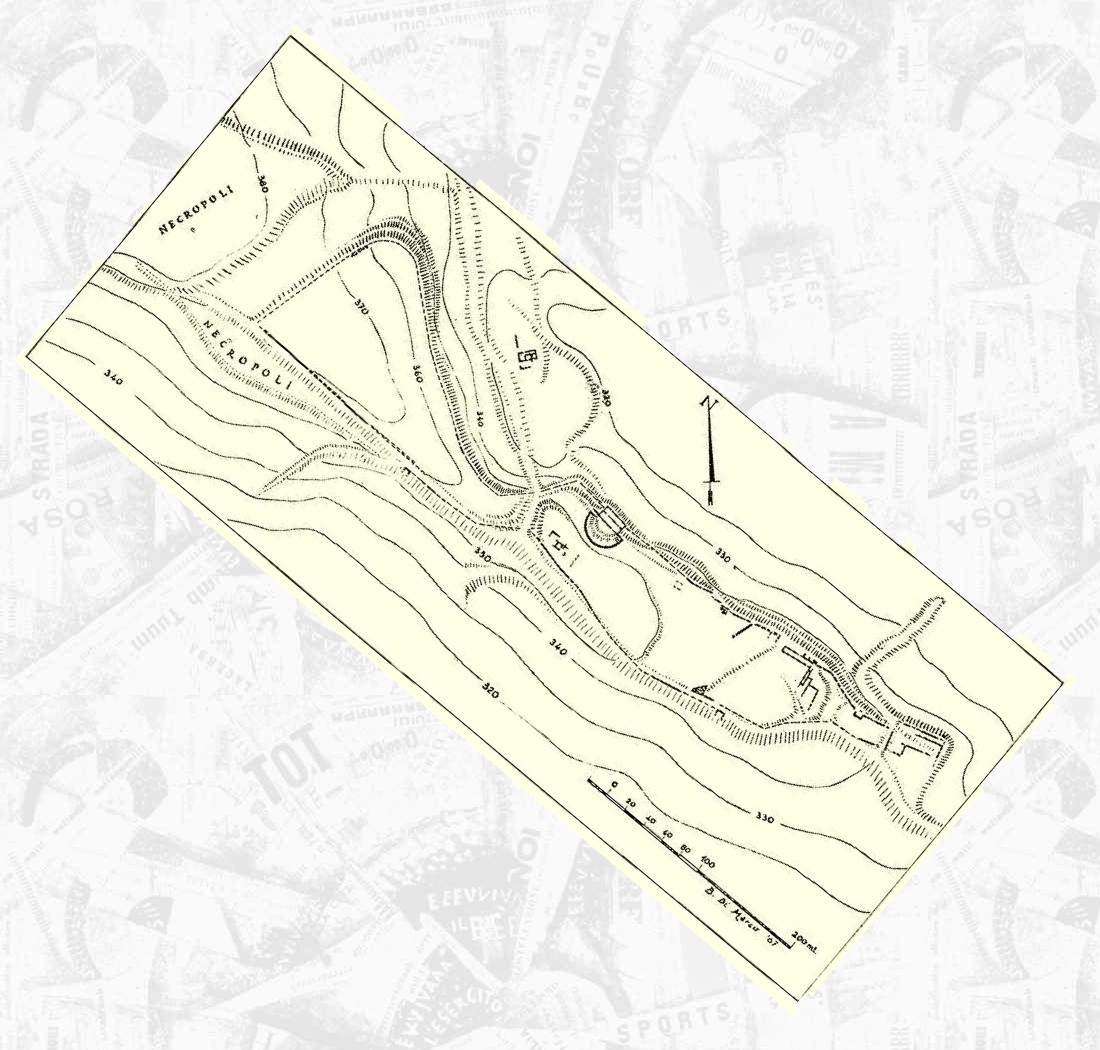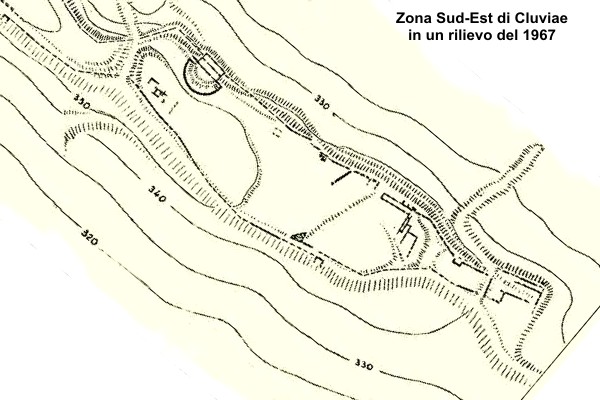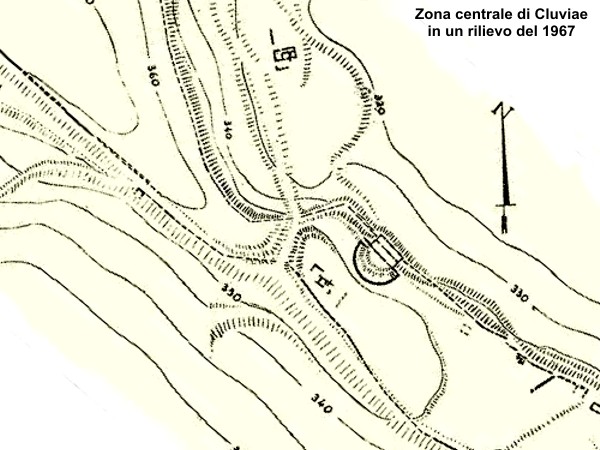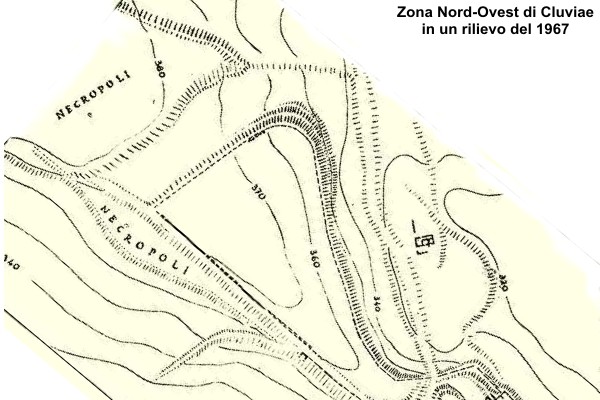Grazie all'acquisizione della tabula patronatus,
documento epigrafico redatto nell'anno 383 d.C. per conto dei Cluvienses Carricini, è stata identificata il
12 Dicembre del 1966,
la città sannitica di Cluviae nella località chiamata Piano Laroma, che era però all'epoca conosciuta come
Pagus Urbanus
In quel
periodo, l'attività edilizia era regolata da un semplice Piano di
Fabbricazione, questo fino alla metà degli anni '80, quando finalmente con
l'adozione del primo PRG, la zona delimitata dalla Soprintendenza nel 1977 sulla mappa catastale
(clicca), viene recepita dal nuovo strumento urbanistico.
Come si
evince dalla foto aerea inserita, il territorio, negli anni successivi
alla identificazione dell'antica città, ha comunque subito
trasformazioni derivanti da un'attività edilizia non (o poco) controllata e, dopo
ben 42 anni, si riscontrano carenze anche nell'ultimo PRG (leggi),
in quanto, le zone edificabili intorno all'area archeologica, dove,
secondo il rilievo del '67 redatto dalla Soprintendenza di Chieti,
si estendono le necropoli, non sono salvaguardate dai nuovi
insediamenti. Sottoporre a tutela tramite strumento urbanistico Comunale,
anche la fascia limitrofa della zona archeologica, non significa vietare
qualsiasi attività edilizia, ma dare la possibilità al Comune di
vigilare e controllarla meglio durante gli scavi di sbancamento (che
potrebbero riportare alla luce antiche tombe) e, soprattutto, dare la
possibilità di regolamentarla con norme specifiche inerenti la
tipologia costruttiva e l'uso dei materiali, poichè, quelle
generiche del PRG non bastano. Tutto ciò è necessario, al fine di evitare che
intorno alla zona archeologica si continui a costruire
manufatti rurali o
insediamenti produttivi che somigliano a capannoni industriali.
E'
vero che l'area archeologica di Cluviae ha bisogno di altri fondi per
nuove campagne di scavi (l'ultima risale al 1990), ma è necessario
prima di tutto conservarla mediante lavori di ripristino e
manutenzione (simili all'intervento effettuato dalla
Soprintendenza del mese di
Giugno 2008) e poi rivalutarla,
promuovendo e sostenendo un Progetto di Recupero, che
riesca ad innescare un processo inverso avvenuto finora,
controllando in maniera dettagliata ogni attività edilizia sui manufatti
esistenti tramite l'individuazione di un intervento specifico per
ogni singolo edificio che aiuti il progettista a ridurre al minimo l'impatto
negativo che oggi molti di questi manufatti rurali hanno sulla zona, inoltre, il
citato P.R. dovrà consentire ai privati di gestire nuove attività
compatibili con l'interesse culturale dell'area.
IMMAGINI A CONFRONTO