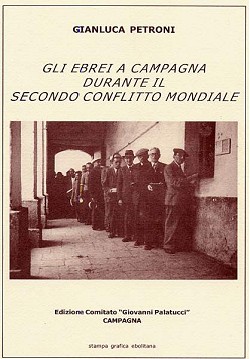|
Campo per ebrei a Casoli
Attivato il 14 Giugno del 1940 e composto da due edifici, il campo di Casoli era occupato da circa 80 internati. Il campo cessò di funzionare appena dopo l'8 Settembre del 1943
Shoah
di
Maria C.
Ricci
Palazzo Tilli visto dalla copertura del fabbricato
adiacente che ospitava il vecchio Cinema
Tutti i link correlati»
Nel 1940, vengono impiantati i primi 43
campi per ebrei in Italia, tra gli internati vi erano anche
zingari e antifascisti. Ma quanti furono in totale i campi di deportazione in
Italia ?
Renzo De Felice nel suo libro "Storia degli ebrei
sotto il fascismo", parla di circa 400 tra luoghi di confino e
campi di internamento; Fabio Galluccio, nel suo saggio del 2002
"I lager in Italia" (Non Luoghi Editore), parla di
duecento luoghi di deportazione fascisti, lager in cui erano rinchiusi ebrei,
dissidenti politici, stranieri, zingari e omosessuali, senza contare i luoghi di
"semplice" confino. Rimane comunque, ancora oggi, difficile stabilire
con precisione il numero dei campi di concentramento istituiti in Italia.
Nei campi era previsto
l’internamento di coloro che erano ritenuti pericolosi, nei comuni gli
elementi meno pericolosi, mentre per i sospetti di spionaggio era previsto il
confino in località insulare. In ogni regione vi era almeno un campo situato in
posti isolati e poco salubri, oppure dove l’inverno era rigido come in
montagna e gli edifici erano fattorie, vecchie fabbriche, ville requisite, altri
locali pubblici o di interesse pubblico dismessi, vecchie scuole o cinema). I
campi potevano essere gestiti da civili o militari o potevano essere misti o
solo femminili come quello di Lanciano (Ch). Le condizioni igieniche erano
degradanti: mancanza di isolamento termico, forte umidità, infissi difettosi,
strutture pericolanti, poca luce ed aria, sovraffollamento e presenza di ratti,
insetti, cimici e pidocchi. Anche l’assistenza sanitaria era spesso carente,
in quanto poteva essere respinta o accettata illegittimamente. A tutto questo,
si aggiungeva la malnutrizione che andava ad aumentare la lista delle malattie
causate anche dalle scarse condizioni igieniche e dalla carenza di assistenza.
Carlo Spartaco Capogreco, in "I
Campi di internamento fascisti per gli ebrei (1940-1943)" scrive :
«Ancora un ebreo tedesco, internato a Casoli, così si esprimeva nel 1940,
scrivendo al fratello in Sud America: "Viviamo ora in un periodo
critico, e non si può sapere se ne uscirò vivo... Io sono in buona salute e non
posso lamentarmi. Se si potesse attendere qui la fine della guerra, sarebbe già
una buona cosa, ma non si sa cosa possa ancora succedere. . . "
» . Nel 1943 molti internati, soprattutto ebrei stranieri, sloveni e croati si
trovavano ancora rinchiusi nei campi d’internamento, finendo così nelle mani
dei nazisti che li deportarono in Germania o nei campi di sterminio in Polonia.
L’Abruzzo, per la scarsità delle
vie di comunicazione, per la scarsa concentrazione abitativa, per i luoghi
impervi, per la minore politicizzazione degli abitanti e per l’assenza di zone
militarmente importanti, rappresentava una delle regioni, che, più delle altre,
aveva tutti i requisiti richiesti dal Ministero dell’Interno per poter
istituire campi di concentramento e località d’internamento. Il 6 giugno
1940, la Prefettura dell’Aquila inviò un elenco dei comuni dove poter
assegnare i destinati all’internamento "libero"; essi erano:
Alfedena, Ateleta, Campo di Giove, Cappadocia, Castel di Sangro, Ortona dei
Marsi, Pereto, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pizzoli, Rocca di Mezzo, Villetta
Barrea. In queste località vennero internati, per la maggior parte, ebrei
italiani, le cui condizioni variarono a seconda del luogo d’internamento.
Quella dell’Aquila sarà la sola provincia abruzzese dove non verranno
istituiti campi di concentramento.
«L’Ispettore Generale di P.S.,
Roberto Falcone, - scrive Costantino Di Sante in "I
campi di concentramento in Abruzzo (1940-1944)" - trasmise, il
27 aprile 1940, al Ministero dell’Interno, l’elenco dei fabbricati della
provincia di Chieti dove potevano essere inviati gli internati:
| 01 |
edificio dell’asilo infantile Principessa di Piemonte, di
Chieti, di proprietà del comune, con 350 posti; |
| 02 |
ex scuola nel comune di Casoli con 30 posti, e locali
di proprietà dell’Avv. Vincenzo Tilli, con 100 posti; |
| 03 |
palazzina nel comune di Lanciano , in contrada
Cappuccini, di proprietà dell’Avv. Filippo Sorge, con 100 posti; |
| 04 |
fabbricato nel comune di Fossacesia, di proprietà dei
coniugi Majer e Gilda Lotti, con 100 posti; |
| 05 |
palazzina nel comune di Francavilla al Mare, di
proprietà del Cav. Giuseppe Gallo, con 100 posti; |
| 06 |
fabbricato del comune di Miglianico, di proprietà dei
fratelli Tomei, con 120 posti; |
| 07 |
fabbricato del comune di Tollo, di proprietà del Cav.
Giuseppe Foppa Pedretti, con 250 posti; |
| 08 |
fabbricato nel comune di Lama dei Peligni, di
proprietà del Banco di Napoli, con 100 posti; |
| 09 |
fabbricato nel comune di Lama dei Peligni, di
Proprietà della vedova Camilla Borrelli, con 150 posti; |
| 10 |
fabbricato del comune di Istonio, di proprietà
dell’Avv. Oreste Ricci, con 300 posti; |
| 11 |
fabbricato del comune di Istonio, di proprietà
degli eredi Marchesani, con 180 posti; |
| 12 |
fabbricato nel comune di Casalbordino, di proprietà
del sig. Germano Sanese, con 350 posti. |
Per quanto riguarda le località d’internamento, nella
provincia di Chieti vennero interessati i comuni e le località di Archi,
Atessa, Bomba, Bucchianico, Carunchio,
Casalbordino, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino,
Celenza sul Trigno, Cupello, Fara Filiorum Petri,
Fresagrandinaria, Gissi, Guardiagrele, Lanciano,
Montazzoli, Orsogna, Palena, Paglieta, Quadri,
Rapino, Ripa Teatina, Roccaspinalventi, San Buono,
Scerni, Toricella Peligna, Villamagna e Villa S. Maria.»
Dopo aver individuato le località e gli
edifici adatti per l’internamento, compito delle Prefetture era quello di
acquisire lo stabile. Se era di proprietà privata si doveva stipulare un
contratto di locazione con i proprietari. Una volta acquisito l’edificio, si
sarebbe dovuto procedere all’occupazione "mezzo arma" dei
fabbricati. Questa consisteva, nella creazione di un posto fisso di RR.CC.
all’interno del campo oppure, se ciò non era possibile, in un edificio
vicino.
"I cinque anni rubati"
Wilhelm Baehr , un ebreo internato a Campagna, racconta anche l’esperienza
vissuta a Casoli
Il racconto è contenuto nel libro "Gli ebrei a Campagna
durante il Secondo Conflitto Mondiale" di Gianluca Petroni
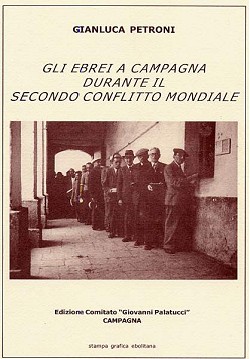 |
Ne parla Gianluca Petroni nel suo libro
"Gli ebrei a Campagna durante il secondo conflitto mondiale"
: «Nel settembre del 1941, insieme con 50-60 internati, Baehr fu
trasferito a Casoli, vicino Pescara, dove, a differenza di Ferramonti, regnava
un’atmosfera decisamente diversa. C’erano due campi di concentramento, uno
situato in una ex scuola e l’altro in una ex sala cinematografica dove fu
appunto destinato Baehr. Egli ricorda in particolar modo il bellissimo panorama
offerto dal punto in cui era ubicato il campo e anche che, nelle montagne
circostanti, c’erano numerosi e piccoli centri abitati nei quali vivevano
intere famiglie ebree in internamento libero, a cui egli, così come gli altri
internati, erano soliti fare regolare e gradita visita.
L’appello giornaliero, ricorda Baehr, fu ben presto eliminato perché le
guardie avevano ormai capito la serietà e la bontà delle persone con cui
avevano a che fare. Nell’ex cinema gli internati avevano anche una grossa
"sala Giorno", così chiamata da Wilhelm Baehr, dove abitualmente si
leggeva e giocava, anche in compagnia degli altri internati provenienti
dall’ex scuola, l’altro campo di concentramento; generalmente si giocava a
carte o a scacchi fino a notte inoltrata; il cibo veniva preparato dagli stessi
internati ma c’era anche la possibilità di andare a mangiare in trattoria per
pochi soldi.
A questo riguardo Baehr ricorda che, paradossalmente, erano proprio gli
internati a popolare i più grandi caffè del posto; anche la religione poteva
essere praticata senza nessun problema, così come la possibilità di inviare e
ricevere posta, ovviamente sottoposta a censura dalle autorità competenti.
Tutto questo ha contribuito indubbiamente a far sì che Wilhelm Baehr
conservasse un ottimo ricordo dell’esperienza vissuta a Casoli.
Nel maggio 1942 però, il campo di concentramento di Casoli fu chiuso e tutti
gli internati furono trasferiti al campo di concentramento di Campagna.
Relativamente al periodo trascorso al campo di S. Bartolomeo e a quello
successivo, si è ritenuto opportuno riportare integralmente quanto scritto in
proposito da Wilhelm Baehr: "Purtroppo però, questo lager fu chiuso e
tutti gli internati furono trasferiti, nel maggio 1942, a Campagna (prov. di
Salerno), dove trovammo già 130 compagni. Il nostro campo di concentramento era
un vecchio chiostro, situato nel punto più alto del luogo, al quale si accedeva
attraverso una scala di circa 3-400 gradini da Campagna. Anche questo posto è
situato in una posizione molto bella, circondato da alte montagne in un contorno
molto romantico. La popolazione, costituita da circa 200 anime, è povera e
le abitazioni sono molto sporche. Spesso abitano insieme animali e uomini in un
unica stanza, come ha descritto Carlo Levi nel suo famoso romanzo 'Cristo si è
fermato a Eboli'. Inoltre gli abitanti sono ad un livello culturale molto basso,
quasi nessuno sa leggere e scrivere, per cui non abbiamo potuto stabilire alcun
contatto con loro. D’altra parte da noi, grazie alle più grandi maestranze
tra circa 200 persone, si sviluppò la vita sociale molto più che a Casoli."»
Casoli, il campo per gli ebrei
Tratto da : "I campi di concentramento in Abruzzo
(1940-1944)" cap. 2.3
di Costantino Di Sante
«Il campo di concentramento di Casoli venne attivato il
14
giugno 1940 ed era composto da due edifici: uno di proprietà dell’avv.
Vincenzo Tilli con la capienza di 50 posti (vecchio cinema) e l’altro era una
ex scuola comunale con 30 posti .
Nella relazione dell’Ispettore Falcone sui "possibili campi" in
provincia di Chieti, come già accennato nel paragrafo precedente, il campo di
Casoli, era indicato come sede idonea per l’invio degli internati più
pericolosi. Il Ministero dell’Interno, invece, vi internò principalmente
ebrei di nazionalità tedesca e austriaca. Dalla stessa relazione erano stati
preventivati 80 posti per l’edificio dell’avv. Tilli, ma dopo un sopralluogo
del Genio Civile, che escluse il seminterrato perché umido e non idoneo, tali
posti vennero ridotti a 50.
La direzione del campo era affidata al Podestà del paese Mosé Ricci; il
compito della sorveglianza ricadeva su un sottufficiale e sei carabinieri,
assegnati a questo scopo dalla locale stazione, l’assistenza sanitaria era
assicurata dal Dr. Nicola Ramondo.
Le condizioni degli internati di Casoli, se raffrontata a quella di altri campi,
all’inizio non furono particolarmente dure. Questo grazie alla conduzione del
Podestà, che, come accadde in altre località, applicò in modo blando le
disposizioni previste per l’internamento, e grazie anche all’atteggiamento
comprensivo della popolazione locale.
Questa mite direzione da parte del Podestà provocò la reazione dei fascisti
del luogo, i quali, il 16 ottobre 1940, fecero pervenire una lettera al Capo
della Polizia della Questura di Chieti. Nella lettera si denunciava
l’internato polacco Hermann Datyner, perchè esercitava la professione di
medico nel paese, e il Podestà perché ne elogiava le capacità professionali.
Dopo gli accertamenti da parte della polizia, Hermann Datyner venne trasferito
al campo di Istonio, mentre per il Podestà non ci furono conseguenze.
Al di là di questo episodio, la condizione degli internati divenne comunque più
difficile nei mesi successivi a causa del sovraffollamento e della carenza di
vitto denunciata dagli stessi internati medesimi nel mese di agosto 1942 durante
l’ispezione dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana e di quella
Internazionale.
I primi internati giunsero a Casoli verso la metà di luglio 1940 e il 14 dello
stesso mese si contavano già cinquanta internati in maggioranza tedeschi di
religione ebraica.
Nell’agosto 1941, a causa dei numerosi trasferimenti, il numero degli
internati si ridusse fino a trenta presenze. Anche se nel mese successivo
arrivarono, provenienti dal campo di Ferramonti di Tarsia, altri 27 internati,
il campo di Casoli per tutto il 1941, e nei primi mesi del 1942, non arrivò mai
alla piena capienza pur se, per problemi di spazio, la capacità recettiva era
stata portata a 70 posti. . Questa venne raggiunta nel maggio del 1942, dopo
che, i 50 internati presenti, vennero trasferiti nel campo di Campagna
(Salerno), e, dal campo di Corropoli, arrivarono 74 internati. Prima
dell’arrivo degli internati di Corropoli, il Ministero trasferì, il 7 maggio
1942, quelli di Casoli, in tutto 50 internati, nel campo di Campagna .
Nell’agosto del 1942 si raggiunsero le 87 presenze, e, in una relazione
dell’Ispettore Generale Rosati, si denunciava che a Casoli i "locali sono
occupati forse anche oltre una adeguata misura e per tanto non solo non vi si
potrebbe inviare altri elementi, ma anzi, se e quando possibile, sarebbe
consigliabile uno sfollamento".
Il numero delle presenze nel campo rimase, fino alla chiusura, sempre elevato e
il 6 novembre del 1942 la Croce Rossa Internazionale, oltre al sovraffollamento,
faceva presente al Ministero dell’Interno che oltre il sovraffollamento,
"gli internati si lamentano per la scarsità e la mancanza di varietà del
cibo, il vestiario insufficiente e lo spazio a disposizione troppo ristretto per
la passeggiata", e, alla fine della relazione, sollecitava il Ministero a
prendere provvedimenti.
Il Ministero, invece, vi continuò ad inviare internati, quasi sempre ebrei,
fino a quando il campo cessò di funzionare subito dopo l’8 settembre 1943.»
|
Elenco
di 50 internati assegnati al campo di Casoli
|
1) Arensberg Willi di
Hermann - ebreo tedesco
2) Beran Bruno di Sigismondo - ebreo tedesco
3) Berolz Heimer Kaus Alberto fu Martino - ebreo tedesco
4) Brasch Kaus di Saly - ebreo tedesco
5) Cohn Rodolfo di Sigismondo - ebreo tedesco
6) Eckstein Oskar Israel di Ugo - ebreo tedesco
7) Fried Erick di Fritz - ebreo tedesco
8) Freund Maso Israel di Edoardo - ebreo tedesco
9) Goldmann Oskar Israel di Samuele - ebreo tedesco
10) Goldstein Bertoldo di Israele - ebreo tedesco
11) Gollerstepper Maso di Israele - ebreo tedesco
12) Harth Heinrich di Fabiano - ebreo tedesco
13) Harnick Isacco di Haim - ebreo tedesco
14) Herzberg Siegbert di Louis - ebreo tedesco
15) Hochsstimm Kaus Walter di Rodolfo - ebreo tedesco
16) Klarfeld Giacomo fu Leo - ebreo tedesco
17) Klein Alessandro fu Giuseppe - ebreo tedesco
18)
Lager Sigfrido fu Giuseppe - ebreo tedesco
19) Loew Riccardo di Joseph - ebreo tedesco
20) Loewenstein Fritz di Israel - ebreo tedesco
21) Segall Maximilian Israele di Saly - ebreo tedesco
22)
Weinberg Arturo di Kermann - ebreo tedesco
23) Choczner Salomone fu Moises - ebreo apolide
24) Bettinger Salomone Mannes di Pinkas - ebreo apolide
25) Furst Arturo di Magnose - ebreo apolide
26) Gorlin Lazar di Elias - ebreo apolide
27) Grauer Samuel di Marco - ebreo apolide
28) Grun Marco di Israel - ebreo apolide
29) Heber Isacco di Giacobbe - ebreo apolide
30) Hassaid Giuseppe di Behor - ebreo apolide
31) Hellmann Ralfh di Giacomo - ebreo apolide
32) Hochberger Woicech Bela di Simeone - ebreo apolide
33) Karp Mayer di Giuseppe - ebreo apolide
34) Kuznitzri Bertoldo di Manfredo - ebreo apolide
35) Lipmanovicz Samuele di Efraim - ebreo apolide
36) Marder Marco di Giuseppe - ebreo apolide
37)
Nagler Salo fu Giacomo - ebreo apolide
38) Pitzela Hermann di Masc - ebreo apolide
39) Rothemberg Mandel di Salomone - ebreo apolide
40) Widder Abramo di Giovanni - ebreo apolide
41) Zylbergerg Jaukiel - ebreo apolide
42) Berl Silvio di Aronne - ebreo polacco
43) Krebs Benedetto di Ignazio - ebreo polacco
44) Wiesenfeld Abramo Isacco fu Nathan - ebreo polacco
45) Wittmann Sigismondo di Enrico - ebro polacco
46) Balint Dionisio di Giuseppe - ebreo ungherese
47) Freilich Emilio di Isidoro - ebreo ungherese
48) Grunhut Marcello Moritz di Emanuele - ebreo slovacco
49) Grunfut Rodolfo di Marcello Moritz - ebreo slovacco
50) Goldemberg Salomone di Israele - ebreo rumeno |
|
ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di P.S., AA.GG.RR.,
cat. Massime M/4, B. 118 |
|
Guarda la foto degli internati a Casoli
|
Mappa
dei maggiori campi di concentramento e di sterminio nazisti»»
Articoli correlati della
Rassegna Stampa»
Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2011 con il collegamento a
questo
nuovo articolo
Inserito da Carmen il 27/01/2004 alle ore 22:24:41 - sez. Storia - visite: 16546
|